|
I
granuli pollinici delle piante costituiscono una
fonte allergenica tra le più importanti.
Il polline è il gametofito maschile, ovvero la
struttura che produce e mantiene i gameti delle
piante a seme (Angiosperme e Gimnosperme).
Il
termine polline è stato coniato da Linneo (il
naturalista svedese artefice della nomenclatura
botanica binomia) e deriva dal latino "pollen" che
vuol dire: farina fine.
I pollini germinano sulla parte femminile dei fiori,
lo stigma, fecondando gli ovuli che produrranno poi
i semi. Quando il granulo pollinico ha raggiunto lo
stigma, emette un tubetto pollinico che attraversa
lo stilo ed indirizza i gameti maschili verso quelli
femminili.
Questi sono situati nel gametofito femminile che si
trova dentro gli ovuli, a loro volta racchiusi
nell'ovaio. Il polline viene prodotto all'interno
delle sacche polliniche che vengono a formare
l'antera. Questa è tondeggiante ed è
composta, dall'interno verso l'esterno dalle
cellule madri del polline, dal tappeto
(che nutre il polline durante il suo sviluppo, dallo
strato mediano (che unisce le varie sacche
polliniche), dallo strato meccanico, che
serve a facilitare l'uscita del polline.
Nelle
Gimnosperme si presenta un'impollinazione quasi
esclusivamente anemofila, cioè tramite il
vento. Nelle Angiosperme si riscontra
un'impollinazione entomofila, tramite gli insetti.
Esistono forme di impollinazione tramite l'acqua e
tramite gli animali. Le piante anemofile producono
elevate quantità di polline, presentano fiori molto
piccoli e poco vistosi, in quanto non devono
attirare gli insetti per l'impollinazione. Il loro
polline può essere trasportato anche a distanze di
centinaia di chilometri dalla sorgente.
Le
piante ad impollinazione entomofila presentano
invece fiori vistosi e profumati, al fine di
attirare gli insetti. Esse producano minori quantità
di polline, che viene trasportato da un'insetto
vettore.
Il polline si presenta sotto forma di granuli di
piccole dimensioni (comprese tra i 10 e i 200
micron). La forma è variabile, ovoidale o
elicoidale. Possono presentare aperture
rappresentate da pori e solchi. Il granulo è formato
da un'involucro esterno molto resistente. Questo
presenta due pareti: una esterna chiamata esina,
formata da sporopollenina, ed una interna, chiamata
intina formata da polisaccaridi.
La
sporopollenina è molto resistente agli agenti
esterni. L'esina inoltre presenta una superficia
molto elaborata, con sculture, ornamenti, disegni
che sono caratteristici per ogni specie e servono a
riconoscerle ed a distinguerle. L'interno del
polline presenta un contenuto ricco di proteine e
glicoproteine allergizzanti.
Questo materiale fuoriesce dall'involucro tramite le
aperture del granulo pollinico (solchi o pori).
Non
appena un polline raggiunge una mucosa (ambiente
umido), inizia entro pochi secondi a liberare il
proprio contenuto allergenico, nella maggior parte
dei casi costitutito da materiale proteico.
Si ipotizza che, in determinati pollini, come quelli
delle Cupressaceae, assumano importanza anche
allergeni di natura carboidratica.
Il
tappeto, durante la formazione dell'esina, forma dei
piccoli corpi rotondeggianti, tra 1 e 5 micron,
denominati orticoli o corpi di Ubish. Di
questi si è ipotizzata la natura allergenica, ma una
dimostrazione di questa ipotesi non è mai stata
portata, né esiste prova che i corpi di Ubish
abbiano reale potere allergenico e non svolgano
invece solo un ruolo di protezione e di cuscinetti
meccanici nello scivolamento del polline all'esterno
dell'antera.
Siccome i pollini hanno dimensioni medie superiori
ai 10 micron, queste non consentirebbero la loro
penetrazione nelle vie aeree inferiori. Questa
considerazione pone agli studiosi su come avvenga il
contatto tra l'allergene pollinico e la mucosa
bronchiale.
L'allergene potrebbe essere associato a particelle
di dimensioni inferiori al micron e derivate dal
granulo pollinico. Esistono ancora dubbi e
incertezze su dove siano situati questi allergeni
(orticoli? citoplasma?) e su come avvenga la loro
liberazione.
Non si conosce il numero di granuli pollinici
necessario per provocare sintomatologia, nei
soggetti sensibilizzati.
Alcuni
studi indicano che questo numero varia a seconda
della prima esposizione. La quantità di polline
necessaria per far iniziare i sintomi è sempre più
elevata all'inizio della stagione pollinica,
piuttosto che nel corso della stagione. Questo
fenomeno è stato definito "primig effect"
ovvero effetto scatenante.
Non esistono molti studi sulla dose soglia di
concentrazioni allergeniche, e questa certo varia a
seconda della diversa specie pollinica, oltre che
del periodo di fioritura (iniziale o terminale). |
|
|
|
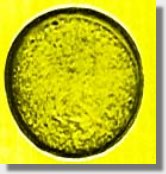 |
Famiglia che include numerosi generi, sia spontanei
che coltivati. Le presenze maggiori di questi
pollini sono nella valle padana, negli Appennini
centrali, in Campania ed in Sardegna. La fioritura
va da aprile a giugno. Le diverse specie di
Graminaceae cross-reagiscono ampiamente tra di loro.
La prevalenza per sensibilizzazione varia, a seconda
delle diverse regioni italiane dal 75% al 30%. La
famiglia delle Graminaceae risulta molto omogenea
anche dal punto di vista della morfologia pollinica
per cui è difficile, nella maggior parte dei casi,
un loro riconoscimento nell'ambito della famiglia,
almeno con il microscopio ottico.
I granuli pollinici sono sferoidali od ovoidali, con
diametro che può variare da 22 a 122 micron. L'esina
è sottile, l'intina è più spessa. La superficie
esterna dell'esina è in genere finemente cabrata.
Presentano un'apertura rappresentata da un poro di
2-8 micron di diametro. |
|
|
|
|
La specie più
importante è la Parietaria, molto comune,
cresce sui ruderi e sui muri, lungo le
strade e i fossi. Fiorisce da marzo ad
ottobre. La concentrazione di questo polline
è molto alta nelle regioni del Sud Italia ed
in Liguria. La pollinazione, in queste aree
geografiche, è praticamente presente durante
tutto l'arco dell'anno, con due picchi di
fioritura: uno maggiore, in marzo-aprile, un
secondo, di minore grandezza, in settembre.
La prevalenza di questa sensibilizzazione è
intorno al 60-70 % nelle aree del Sud, Isole
ed in Liguria (che costituisce un'eccezione,
tra le regioni settentrionali). Nelle
regioni del Nord la prevalenza oscilla tra
il 20 e il 40%. |
 |
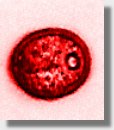 |
Il polline
di Parietaria è di piccole dimensioni (10-15
micron), sferico, triporato ovvero dotato di
tre aperture sferoidali denominate "pori".
Questi sono isodiametrici ed in posizione
equatoriale. In corrispondenza dei pori lo
strato più interno della parete diventa più
spesso, formando degli onci. Il polline
dell'Urtica dioica è molto simile a quello
della Parietaria, ma è raramente
sensibilizzante ed in questi casi non esiste
cross-reattività tra le due specie. |
|
|
|
|
|
La
specie di maggior significato clinico è
rappresentata dall'Olea europea.
La sua pollinazione si verifica in maggio e in
giugno. Le zone geografiche più interessate sono
lungo le coste mediterranee e le Isole. La
prevalenza di sensibilizzazione in queste aree va
dal 15 al 25 % Nelle altre aree italiane, nel Nord,
dove gli olivi sono scarsi in numero e dove sono più
presenti i frassini, la frequenza di
sensibilizzazione non supera il 5%.
Il polline è di dimensioni medie (20 micron),
sferoidale, isopolare.
Presenta tre aperture (polline tricolporato) con
onci a livello delle aperture. La superficie è
reticolata. |
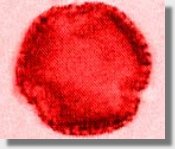
|
|
|
|
|
 |
Sono una specie la cui
importanza allergenica è stata rivalutata negli
ultimi anni. Si ipotizza un incremento dei casi di
sensibilizzazione dovuto all'aumento del numero di
piante impiantate a scopo di forestazione ed
ornamentale ma non sono esclusi anche altri fattori
relativi ad un'aumentata aggressività del polline,
per cause ancora da definire e verosimilmente legate
all'inquinamento da motori diesel. Una recente
indagine policentrica italiana ha definito una
prevalenza media ci circa il 18% con punte intorno
al 30% in Toscana ed in Liguria, dove queste piante
sono molto ben rappresentate. I granuli pollinici
delle diverse specie di Cupressaceae non sono
distinguibili tra di loro, al microscopio ottico.
Sono apolari, inaperturati, sferoidali. Le
dimensioni sono intorno ai 25-30 micron. L'esina è
sottile e la superficie psilata presenta orticoli
(corpi di Ubish) distribuiti irregolarmente.
L'intina è di spessore variavile e conferisce al
granulo la caratteristica forma stellata. Il granulo
ha la tendenza a rompersi. I granuli hanno una
prevalente composizione in carboidrati (80%) a
differenza degli altri pollini. |
|
|
|
|
In
questa famiglia (che presenta un'impollinazione
prevalentemente entomofila) vi sono numerosi generi.
In Italia circa 20 specie. La più comune è
l'Artemisia vulgaris. L' Ambrosia, che, fino ad
alcuni anni fa, era un allergene pollinico diffuso
soltanto negli U.S.A., ha iniziato a dare segni di
presenza anche in Italia, nelle aree del Nord. Il
territorio italiano in cui l' Ambrosia è
maggiormante presente è la Lombardia, probabilmente
per la presenza dell'aeroporto internazionale della
Malpensa, dove potrebbero essere giunti i semi dagli
U.S.A.
I granuli pollinici delle varie specie di dimensioni
tra i 20 e i 25 micron. La parte del polline è
alquanto spessa con tendenza ad assottigliarsi in
prossimità delle tre aperture. Per questo motivo i
granuli pollinici di Compositeae assumono forma
trilobata. L'esina presenta scabrature e
microechinature.
La pollinazione di queste piante avviene nel perido
che va da luglio a settembre. La prevalenza di
sensibilizzazione alle Compositeae va dal 10 al 25
%. |

|
|
|
|
 |
Negli
ultimi decenni, in Italia, si è verificato
un incremento delle sensibilizazioni a
specie arboree come queste: Corylus, Ostrya,
Carpinus, Betulla, Alnus. Queste specie sono
tra di loro cross-reagenti. La pollinazione
parte precocemente, da gennaio a maggio. La
prevalenza di sensibilizzazione può
raggiungere il 15%.
Il polline di Betulla spp ha profilo
tondeggiante o elittico, triporato, con i
tre pori sporgenti sulla linea equatoriale.
La parete
si ispessisce e si solleva in corrispondenza
delle aperture.
Dimensioni intorno ai 22 micron. |
|
L'esina è
piuttosto sottile, con tetto liscio o
scabro. Il polline di Corylus avellana ha un
profilo triangolare, tre aperture
tondeggianti, pori, con onci molto convessi. |
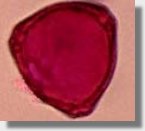 |
|
|
|
|
|
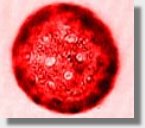 |
Sono piante
allergeniche presenti soprattutto sulle zone
costiere. Prediligono terreni ricchi di sali. Si
sviluppano in terreni incolti e ruderi. Sono piante
erbacee annue con fioritura estiva ed autunnale.
Il granulo pollinico è sferoidale. Dimensioni: 24
micron. Presenta un gran numero di pori, almeno
trenta, provvisti di opercolo. L'esina è sottile. |
|
|
|
|
Famiglia affine alla precedente, con periodo di
fioritura da giugno a settembre, con maggiore
presenza al Sud. |
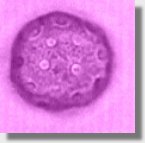
|
|
|
|
|
 |
Piante
presenti su tutto il territorio italiano. Tra queste
importanti quelle del genere Mercurialis (M.
perennis, M. annua, M. corsica) a fioritura molto
prolungata. La prevalenza in italia sarebbe intorno
al 10%. Assieme a queste va ricordato il Ricinus
communis, pinata spontanea presente sia al Sud che
in Liguria che presenta una notevole
allergenicità.Occorre ricordare che anche l' Hevea
brasiliensis, da cui deriva il lattice della gomma
naturale, causa di numerosi casi di
sensibilizzazioni, appartiene a questa famiglia. |
|
|
|
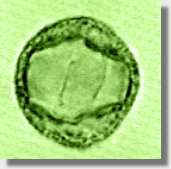 |
Rappresentate
da faggio, quercia, castagno. Fioriscono
d'estate. Sono dotati di scarsa
allergenicità.
I granuli
pollinici sono dimensioni piccole.
La forma è
ovoidale con tre aperture circolari e
sporgenti, al centro di tre lunghi solchi. |
 |
|
|
|
|
|
Presentano numerosi generi quali Cedrus, Pinis,
Picea, Larix, ecc. Possiedono scarso potere
allergogeno. La fioritura va da marzo a maggio.
Il
granulo pollinico di Pino è formato da tre parti: un
corpo centrale di forma elittica con ai lati,
simmetricamente, due sacche ripiene d'aria
(vescicole anemofile). Le dimensioni sono da 65 a 80
micron. Presenta un solco sulla superficie distale.
Il Pinus spp si distingue dalle altre specie per la
presenza di costrizioni nel punto d'inserzione delle
sacche sul corpo. L'esina è spessa a livello del
polo prossimale convesso. Più sottile fino al polo
distale. L'intina è di spessore variabile. |

|
|
|
Visione ottimizzata 1024x768
pixel |
|